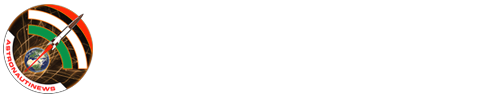Intervista a Sergio Palumberi, ESA Mission Manager della missione Axiom-4

Si è appena conclusa, il 20 luglio 2025 scorso, la missione privata Axiom-4 che ha permesso a quattro membri dell’equipaggio di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e condurre numerosi esperimenti durante i 18 giorni di permanenza a bordo. Tra di loro c’era l’astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, al suo primo volo nello spazio, che ha promosso la missione Ignis dell’Agenzia spaziale europea (ESA), finanziata dal governo polacco e in coordinamento con l’Agenzia spaziale polacca (POLSA).
Nel ruolo di Project Manager e Mission Manager per le attività di ESA durante la missione, c’era l’amico Sergio Palumberi, storico utente di ForumAstronautico, collaboratore di AstronautiNews, e socio ISAA, che lavora presso l’ESA Columbus Control Centre (Col-CC), di Oberpfaffenhofen, nei pressi di Monaco di Baviera in Germania.
Già relatore durante un passato AstronautiCon, ospite di AstronautiCast e nel recente AstronautiMeet dello scorso marzo, ancora una volta si è prestato a rispondere alle nostre domande.
AN: Ci puoi descrivere in cosa consiste il ruolo di mission manager durante una missione sulla ISS.
SP: Il ruolo del mission manager si può descrivere in breve con tre parole in inglese: “make it happen“. Per ogni missione spaziale ci sono molti aspetti da considerare: la scienza, l’ingegneria, la logistica, la sicurezza degli astronauti, la sicurezza informatica, l’addestramento, le pubbliche relazioni, le operazioni, e così via. Per ognuno di questi aspetti, ci sono dei team dedicati, e per ognuno di questi team c’è una persona che coordina il lavoro del proprio team per gli aspetti di quella specifica missione.
Il mission manager supervisiona tutti questi team e si assicura che il loro lavoro porti ad essere pronti in tempo, per poter eseguire con successo tutti gli obiettivi di missione, secondo le priorità definite. E durante l’esecuzione continua a coordinare questi team per verificare che tutto vada secondo i piani, e che si trovino soluzioni ai problemi che inevitabilmente sorgono, perché a fine missione ogni obiettivo sia stato pienamente raggiunto.
Molti dei nostri lettori sono studenti, qual è stato il tuo percorso di studi?
Mi sono diplomato come perito elettrotecnico, e poi ho preso una laurea magistrale in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino, con tesi di laurea all’estero, all’Università di Stoccarda. Dopo la laurea, ho anche conseguito un master di secondo livello in ingegneria dei sistemi, nella prima edizione del master SEEDS, che continua ancora oggi.
Però vorrei aggiungere che, quando gli studenti me lo chiedono, rispondo sempre che nelle missioni spaziali abbiamo bisogno di profili professionali di ogni tipo: ingegneri, fisici, chimici, biologi, dottori, ma anche giornalisti per le pubbliche relazioni, economi per gli aspetti finanziari, o avvocati per seguire gli aspetti legali, che sono importanti in ogni progetto internazionale.
Come si diventa mission manager?
Ci vuole un po’ di fortuna, per trovarsi con il curriculum giusto nel momento giusto. Ma soprattutto credo si debba essere intraprendenti e cercare sempre di espandere i propri orizzonti. Come dicevo prima, il mission manager si deve occupare di tutti gli aspetti di una missione, e quindi deve capire almeno un po’ il lavoro di tutti i team.
Io ho iniziato nell’ingegneria e poi sono passato alle operazioni, dove ho lavorato sia per la ISS che per satelliti in GEO. Sicuramente mi ha aiutato molto lavorare sia in Thales Alenia Space che in Airbus e in DLR, perché ho imparato i loro diversi modi di lavorare, il loro ambiente, e la loro “lingua”. Ma soprattutto, ho sempre cercato di infilarmi dappertutto, senza aspettare di essere invitato, per non perdere nessuna occasione di imparare qualcosa di nuovo, di conoscere qualcuno, e anche di farmi conoscere.
Quanto è durata la preparazione alla missione Axiom-4?
Normalmente la preparazione di una missione per la ISS dura circa un anno, mentre gli esperimenti richiedono di solito un paio d’anni di sviluppo, o anche di più.
ESA ha cominciato a lavorare su Axiom 4 nell’autunno 2023, quindi sono passati quasi due anni prima del lancio. Questo è stato dovuto ai vari ritardi della missione, che inizialmente avrebbe dovuto lanciare nel 2024. Quindi, la preparazione della missione è stata un po’ più lunga del normale, ma questo è stato benefico per gli esperimenti, che hanno avuto poco meno di un anno e mezzo per essere sviluppati e pronti al lancio.
A causa dei due rinvii del lancio (11 e 22 giugno per motivi tecnici) ti sei sentito sotto pressione?
È abbastanza normale che ci siano dei ritardi al lancio, per noi non è stato niente di nuovo.
Un aspetto importante è tenere gli esperimenti biologici sempre pronti al lancio. Per gli scienziati questo significa stare in laboratorio al sito di lancio, per mantenere le colture batteriche e pulire e riempire di nuovo l’hardware di volo ad ogni tentativo di lancio.
Un altro aspetto interessante è la quarantena. Per causa dei ritardi, l’equipaggio di Ax-4 è rimasto in isolamento per un mese. Per ogni suo astronauta, ESA assegna un dottore nel ruolo di Flight Surgeon, per seguire gli aspetti medici durante la preparazione, l’esecuzione e il rientro della missione. Questo dottore condivide l’isolamento con gli astronauti durante la quarantena, e ne controlla anche lo stato psicologico. Nel caso del nostro astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, è andato tutto molto bene.

La pianificazione è stata rispettata? Gli obiettivi della missione sono stati raggiunti?
Gli imprevisti ci sono sempre. Per quanto si possa preparare tutto in ogni minimo dettaglio, come dice Goethe, “grigia è ogni teoria e verde l’albero d’oro della vita“. La realtà riesce sempre a sorprenderci e a trovare qualcosa a cui non avevamo pensato.
Ma se ci si è preparati bene, si è anche pronti a reagire agli imprevisti, e con un po’ di fortuna e di fatica anche a risolvere in tempo ogni anomalia. E questo è stato il caso della missione Ignis, che ha raggiunto il 100% degli obiettivi primari di Sławosz ed è andata oltre, con un 30% di obiettivi aggiuntivi per lui, ma anche molti dati scientifici in più, grazie alla partecipazione ad alcuni esperimenti da parte degli astronauti non ESA, la comandante Peggy Whitson, l’indiano Shubhanshu Shukla e l’ungherese Tibor Kapu.
In più, abbiamo anche sviluppato e portato a termine con Shukla due esperimenti per conto dell’Agenzia spaziale indiana (ISRO).
Dopo il rientro a Terra degli astronauti con lo splashdown al largo della costa californiana, come termina la vostra missione a COL-CC?
Le operazioni si concludono con lo splashdown, ma la missione va ancora avanti per qualche mese.
Bisogna coordinare il rientro dei campioni scientifici verso le università e centri di ricerca responsabili degli esperimenti, e bisogna occuparsi della riabilitazione degli astronauti.
Non solo, gli astronauti devono ancora completare la raccolta dei dati per gli esperimenti medici (BDC, Baseline Data Collection), per poi confrontare i dati raccolti nello spazio con quelli raccolti a terra. In alcuni casi, queste misure avvengono anche fino a più un anno dopo il rientro.
E infine, bisogna anche coordinare il tour e le pubbliche relazioni dell’astronauta, che sono un aspetto importante di ogni missione, per portare le missioni spaziali nelle case di tutti e chissà, ispirare a studiare materie scientifiche quel bambino che tra qualche anno metterà piede su Marte.
Quale sarà la tua prossima missione?
Se non ci sono troppi stravolgimenti nel piano dei voli, la mia prossima missione dovrebbe essere l’Expedition 75, nel 2026. Ma questo autunno avremo la conferenza ministeriale di ESA, chissà che non venga approvata qualche altra missione interessante.
Quotidianamente ti devi interfacciare con professionisti provenienti da ambiti culturali più disparati; quali sono eventualmente i lati positivi e negativi di questa situazione? Hai avuto problemi di integrazione culturale all’inizio della tua carriera?
Mai avuto problemi per questo motivo, anzi. In inglese la chiamano “fertilizzazione incrociata”, più c’è varietà e più c’è disponibilità di punti di vista diversi e di diversi approcci alla soluzione dello stesso problema.
Studiando un po’ di storia della scienza, si scopre presto che i grandi hanno da sempre avuto scambi a distanza, senza confini. E, specialmente negli ultimi 20 anni, credo che questo sia diventato valido anche per il mondo dell’industria.
Ringraziamo quindi Sergio per la disponibilità e gli auguriamo il consueto Ad Astra.
 Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2026 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.
Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2026 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.